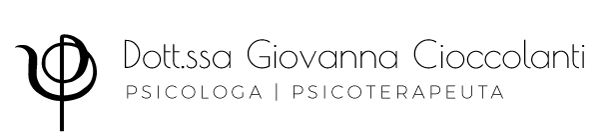C’è una «camicia di forza» che ingabbia la salute e il futuro di ragazze e ragazzi, è una «veste» intrisa di stereotipi di genere che dipingono lei vulnerabile e bisognosa di protezione e quindi incline ad essere sottomessa e lui forte e indipendente. Questi cliché, che si radicano nella mente sin da bambini, limitano soprattutto le ragazze e mettono a rischio la loro salute fisica e psichica e il loro futuro (limitandole socialmente e professionalmente).
Lo rivela il «Global Early Adolescent Study», presentato qualche giorno fa a Washington e frutto di una collaborazione tra Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health e OMS.
Il lavoro, che sarà pubblicato in una serie di articoli sul Journal of Adolescent Health, ha riguardato giovanissimi di 10-14 anni di 15 paesi del mondo, sia ricchi sia in via di sviluppo (Bolivia, Belgio, Burkina Faso, Cina, Repubblica Democratica del Congo, Ecuador, Egitto, India, Kenia, Malawi, Nigeria, Scozia, Sud Africa, the Usa e Vietnam).
Gli stereotipi di genere vengono da lontano e penetrano nella mente sin nei primi anni di vita quando ai bimbi viene proposto un mondo tutto tinto di rosa e azzurro, regno di principesse (belle e passive) e supereroi (armati e violenti).
Diretto da Robert Blum della Johns Hopkins, il lavoro punta l’attenzione sui possibili effetti a lungo termine di questi cliché sulla salute dei giovani.
Lo studio è durato 4 anni e si è basato su una serie di interviste a 450 preadolescenti e adolescenti e 450 adulti di riferimento per ciascuno di loro.
È emerso che senza confini geografici, da Baltimora a Pechino, da Nairobi a Nuova Deli, senza differenze in base al PIL e al grado di libertà o oppressione del singolo paese coinvolto, i bambini si avviano tutti indistintamente nell’adolescenza carichi di stereotipi di genere che sono rinforzati in ogni momento e ad ogni livello (familiare, scolastico, mediatico etc) della loro vita; stereotipi che inducono le bambine (le donne di domani) a considerare il sesso femminile vulnerabile e da difendere e quello maschile come forte e indipendente. Questi stereotipi sono ormai da tempo riconosciuti associati a problemi di salute tra i più disparati che vedono quasi sempre la donna come vittima (dall’HIV e altre infezioni sessualmente trasmesse alla depressione, al suicidio etc).
È emerso, inoltre, che da una parte l’idea stereotipata della femminilità blocca l’accesso delle ragazze al mondo dell’istruzione e poi alla carriera e le espone al rischio di abusi e violenze anche da parte di familiari, specie quando non si conformano al ruolo di genere loro assegnato. Dall’altra, i ragazzi che fanno proprio lo stereotipo maschile di forza e aggressività sono a loro volta a rischio di malattie, abuso di droghe e alcol, violenza e criminalità. Per contro, i ragazzi che non si conformano al cliché maschile, rifiutano le sembianze tipiche del «macho», sono a rischio di emarginazione, bullismo verbale e fisico, vera e propria violenza da parte dei coetanei.
«I rischi per la salute degli adolescenti sono il risultato di comportamenti radicati nei ruoli di genere che - come emerso da questo lavoro - si instaurano nella mente già in età precoce (10-11 anni)», spiega un altro autore, Kristin Mmari. Significa che tutti gli interventi e le campagne che promuovono la salute dei giovani devono cambiare bersaglio, devono in realtà rivolgersi ai bambini e ai preadolescenti per decostruire i ruoli di genere prima che divengano «indelebili» in queste giovani menti.